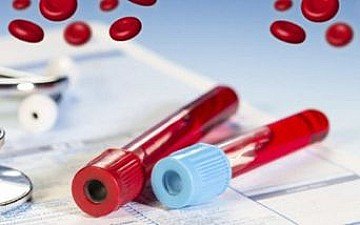Intervista all’Associazione angioedema ereditario ed altre forme rare di angioedema (AAEE ETS)
Negli ultimi anni, il coinvolgimento attivo dei pazienti nei processi decisionali in ambito sanitario è diventato sempre più centrale. Il progetto InPAGs, promosso da RareLab, si inserisce proprio in questo scenario, con l’obiettivo di costruire un modello stabile e qualificato di partecipazione delle associazioni ai percorsi regolatori. Dopo la nascita dell’InPAGs Network nel 2024 e una fase di ascolto e confronto, il progetto ha proseguito nel 2025 con una survey e tavoli tematici, per raccogliere dati e riflettere sulle condizioni di accesso al RUAS e sulle modalità di coinvolgimento.
Nell’intervista che segue, insieme a Pietro Mantovano, Gianmarco Sambataro, Federica Braghieri, rispettivamente Presidente, Vicepresidente e Consigliere di AAEE - Associazione angioedema ereditario ed altre forme rare di angioedema ETS, abbiamo parlato di cosa significa davvero partecipazione, del valore che può portare ai processi decisionali e di come tutto questo si traduca, concretamente, in una migliore qualità della vita per i pazienti.
Pietro, qual è, a suo avviso, l’impatto che ha avuto l’istituzione del RUAS sulle associazioni di pazienti, soprattutto quelle più piccole o basate sul volontariato? Ritiene che la crescente formalizzazione e burocratizzazione dei processi rischi di disincentivare la partecipazione e di generare una disparità di rappresentanza tra le diverse realtà associative?
L’istituzione del RUAS (Registro Unico delle Associazioni della Salute) nasce con l’intento di valorizzare la partecipazione delle associazioni all’interno dei processi regolatori e decisionali, creando criteri chiari e trasparenti per l’interlocuzione anche con l’AIFA. Tuttavia, l’istituzione di questo nuovo registro potrebbe generare non poche criticità, soprattutto per le realtà associative più piccole o composte esclusivamente da volontari. Molte associazioni non dispongono di personale strutturato o risorse economiche dedicate, e la crescente richiesta di adempimenti burocratici e documentali finisce per creare un forte senso di scoraggiamento. Il rischio concreto è che l’accesso al confronto istituzionale diventi un privilegio riservato a poche grandi realtà, spesso professionalizzate, a scapito delle piccole associazioni che, pur rappresentando un numero minore di pazienti, custodiscono un’esperienza diretta, unica e insostituibile di patologie specifiche. È importante non perdere di vista il principio di equità nella rappresentanza: il valore di un’associazione non dovrebbe essere misurato unicamente dal numero di iscritti o dagli anni di attività, ma anche dalla qualità e dalla rilevanza delle sue competenze rispetto a una determinata patologia. In questo contesto, è auspicabile un ripensamento dei criteri di accesso, che tenga conto della specificità delle malattie rare e delle limitazioni oggettive di alcune realtà. Se si vuole incentivare una partecipazione valoriale e rappresentativa, è necessario semplificare le procedure e prevedere strumenti di supporto alla formazione e alla crescita organizzativa, evitando che la burocrazia diventi un ostacolo alla voce dei pazienti.
Quale valore aggiunto potrebbe portare, secondo lei, un dialogo strutturato e continuativo tra AIFA e le associazioni di pazienti, in particolare nei processi di valutazione dell’accesso e della disponibilità dei trattamenti terapeutici?
Un dialogo diretto tra AIFA e le associazioni di pazienti rappresenta un’opportunità strategica per migliorare la coerenza delle scelte regolatorie rispetto ai bisogni reali delle persone che vivono con una patologia. I pazienti non si limitano a ricevere un trattamento: lo integrano nella loro quotidianità, lo confrontano con le proprie esigenze personali, lavorative, familiari. Per questo motivo, il loro punto di vista può fornire indicazioni preziose su aspetti che nessun dato clinico o trial può pienamente restituire: l’impatto sulla qualità della vita, la gestione pratica della terapia, la sostenibilità a lungo termine. L’interlocuzione con i pazienti consente di cogliere la necessità di avere opzioni terapeutiche diverse – anche quando clinicamente equivalenti – per permettere una scelta condivisa medico-paziente basata sulla preferenza individuale, come nel caso della somministrazione orale, sottocutanea o endovenosa. Ogni forma ha vantaggi diversi e può risultare più adatta in funzione dello stile di vita, delle abitudini, o semplicemente delle capacità organizzative della persona. Questo tipo di confronto può dunque orientare le decisioni non solo sulla rimborsabilità dei farmaci, ma anche sull’equità di accesso e sull’importanza di mantenere tutte le opzioni disponibili a livello nazionale. In definitiva, un coinvolgimento strutturato dei pazienti nei processi decisionali non è solo un atto di trasparenza, ma un investimento concreto per garantire terapie più personalizzate, appropriate e sostenibili.
Nel corso degli anni, la collaborazione tra associazioni di pazienti e clinici si è dimostrata un elemento determinante non solo per il miglioramento della diagnosi e della presa in carico, ma anche per la costruzione di percorsi terapeutici più rispondenti ai bisogni reali delle persone. Alla luce della vostra esperienza, in che modo questa alleanza ha contribuito a generare cambiamenti concreti per i pazienti? E ritiene che possa rappresentare, in una logica più ampia, un modello virtuoso da valorizzare anche a livello istituzionale, come esempio di co-progettazione tra società civile e sistema sanitario?
La collaborazione con la rete dei clinici ha rappresentato, fin dalle origini dell’Associazione, un pilastro fondamentale per il progresso nella diagnosi e nella gestione della patologia. Il dialogo costante tra pazienti e medici ha permesso di unire esperienze diverse ma complementari: da una parte, la conoscenza scientifica e clinica della malattia; dall’altra, la quotidianità vissuta dai pazienti, fatta di sintomi, bisogni assistenziali e ostacoli concreti nell’accesso alle cure. Questa sinergia ha prodotto risultati tangibili. Innanzitutto, ha favorito una diffusione capillare della conoscenza della patologia, contribuendo a superare decenni di errate diagnosi o di assenza totale di riconoscimento. Parallelamente, ha consentito di costruire una rete di centri specialistici diffusa sul territorio nazionale, rendendo più equo e sostenibile l’accesso alla diagnosi e alla terapia, anche per chi vive lontano dai grandi centri urbani. Inoltre, questa collaborazione ha avuto un impatto decisivo anche sul fronte terapeutico. Dalla condivisione di dati clinici e osservazioni tra pazienti e medici sono nate vere e proprie traiettorie di sperimentazione, che hanno accompagnato – e in certi casi anticipato – l’arrivo di nuove opzioni terapeutiche, sempre più personalizzabili. Si è passati così dalla terapia endovenosa alla somministrazione sottocutanea, fino alle più recenti terapie orali, con evidenti benefici in termini di aderenza e qualità di vita. Infine, va sottolineato un aspetto forse meno visibile ma altrettanto cruciale: il rapporto costante e strutturato con i clinici ha favorito una cultura condivisa tra pari, nella quale il paziente informato e l’operatore sanitario dialogano come alleati, contribuendo entrambi, con ruoli diversi, a migliorare la presa in carico. Questa esperienza dimostra quanto le reti collaborative tra associazioni e comunità scientifica possano diventare veri motori di innovazione e accesso, soprattutto nell’ambito delle malattie rare, dove la frammentazione e la scarsità di numeri rappresentano ancora una sfida costante. Se il confronto con i clinici ha generato nel tempo valore scientifico e organizzativo, un analogo percorso con le istituzioni – costruito sul dialogo, sul riconoscimento del ruolo delle associazioni e sulla co-progettazione delle politiche sanitarie – può portare frutti altrettanto rilevanti, a vantaggio non solo dei pazienti ma dell’intero sistema.
Federica, dal suo punto di vista di paziente e familiare, quale impatto ha avuto la patologia sulla tua vita quotidiana e quale valore aggiunto pensi che possa portare la testimonianza diretta di un paziente o di un familiare nei processi decisionali legati alle patologie rare?
La patologia ha influenzato profondamente la mia vita quotidiana, non solo dal punto di vista fisico, ma anche psicologico e sociale. Ho vissuto periodi in cui la malattia è stata silente, per poi manifestarsi in modo intenso, soprattutto in momenti di stress come la gravidanza. La gestione della malattia richiede attenzioni costanti, come infusioni regolari e assunzione di farmaci, che incidono sulla routine personale e familiare. Inoltre, c’è la responsabilità verso mia figlia, anch’essa affetta dalla stessa patologia, e le difficoltà di far riconoscere e gestire la malattia nelle attività scolastiche e sociali. Dal punto di vista decisionale, la testimonianza diretta di pazienti e familiari è fondamentale perché porta alla luce la realtà concreta e complessa di vivere con una malattia rara, aspetto che i dati clinici da soli non possono trasmettere. È importante che chi prende decisioni ascolti le difficoltà, le paure e le speranze di chi convive con la malattia, per sviluppare terapie e servizi che rispondano realmente ai bisogni delle persone. Le testimonianze umanizzano il dibattito, sensibilizzano e mettono in evidenza anche le sfide psicologiche e sociali spesso invisibili, rendendo la presenza di pazienti e caregiver indispensabile nei processi decisionali.
Gianmarco, torniamo al tema della collaborazione con i clinici, può raccontarci, anche attraverso la tua esperienza personale e familiare, come questa collaborazione influisce sulla gestione quotidiana della malattia, soprattutto in situazioni di emergenza o interventi non programmati? Inoltre, quale ruolo pensi possano avere il coinvolgimento della medicina generale e l’uso dei registri di patologia nel migliorare la diagnosi?
La collaborazione con i clinici e altri professionisti sanitari è fondamentale per una gestione efficace della malattia, soprattutto in situazioni di emergenza o interventi non programmati. Personalmente, ad esempio, durante un intervento chirurgico d’urgenza, il dialogo diretto con il mio medico specialista ha permesso di garantire la sicurezza del trattamento, e ha contribuito a chiarire i protocolli e la disponibilità dei farmaci necessari. Questo rapporto umano e professionale, che va oltre la semplice prescrizione, permette di affrontare situazioni critiche con maggiore tranquillità e sicurezza. La partecipazione attiva del paziente, che conosce profondamente la propria patologia, diventa così un elemento chiave non solo nel monitoraggio della malattia, ma anche nella comunicazione con i medici, nelle scelte terapeutiche e nella gestione quotidiana. Nel mio caso, ho imparato a riconoscere tempestivamente i sintomi e a trattarli con tempestività, evitando peggioramenti. Questo è stato possibile anche grazie al supporto continuo dei clinici e alla mia partecipazione consapevole al percorso terapeutico. Inoltre, è importante ampliare il coinvolgimento non solo degli specialisti, ma anche della medicina generale, perché spesso sono i primi a entrare in contatto con i pazienti e la loro conoscenza può fare la differenza tra una diagnosi precoce e un ritardo che compromette la qualità della vita. Qui l’uso dei registri di patologia diventa cruciale: raccogliere dati accurati e aggiornati permette di migliorare la conoscenza della malattia, orientare le strategie diagnostiche e terapeutiche, e favorire una rete integrata tra specialisti, medici di famiglia e pazienti. In definitiva, una partecipazione attiva e informata dei pazienti e dei familiari, supportata da una stretta collaborazione con tutti i professionisti sanitari e da strumenti come i registri, è essenziale per migliorare la qualità di vita delle persone affette da malattie rare come l’angioedema ereditaria.
Quanto può influire, secondo te, la modalità di somministrazione di una terapia (ad esempio orale rispetto a infusioni o iniezioni) sulla qualità della vita, in particolare nei bambini? In che modo passare a terapie più semplici da gestire può migliorare la quotidianità e l’autonomia dei più piccoli?
L’impatto della modalità di somministrazione di una terapia sulla qualità della vita è spesso sottovalutato, ma rappresenta un elemento cruciale, soprattutto quando si parla di trattamenti a lungo termine. Per un adulto, affrontare un’infusione o un’iniezione può essere una sfida, ma spesso è qualcosa di gestibile e accettato come parte della routine terapeutica. Per un bambino, invece, questa esperienza può diventare un vero e proprio ostacolo: la paura dell’ago, il dolore momentaneo, e la necessità di dipendere da un adulto per la somministrazione limitano non solo il suo benessere fisico, ma anche la sua autonomia e la possibilità di vivere pienamente le esperienze quotidiane come la scuola, il gioco o i centri estivi. Il passaggio a terapie con modalità di somministrazione più semplici, come quelle orali, rappresenta quindi un enorme passo avanti non solo dal punto di vista medico, ma anche dal punto di vista psicologico e sociale. Ridurre l’invasività del trattamento significa favorire l’indipendenza del paziente, diminuire lo stress associato alla terapia e permettere una vita più normale e serena, soprattutto nell’età pediatrica. Tuttavia, queste sfumature e le difficoltà che ne derivano non possono essere pienamente comprese da chi osserva dall’esterno. Solo chi vive quotidianamente l’esperienza di dover gestire una terapia regolare conosce davvero il peso che può avere una semplice modifica nella modalità di somministrazione. Quindi, è fondamentale dare voce a chi affronta queste sfide ogni giorno, perché sono proprio le loro testimonianze a far emergere il vero valore di certi progressi terapeutici, andando oltre la pura efficacia clinica e abbracciando la qualità di vita complessiva.